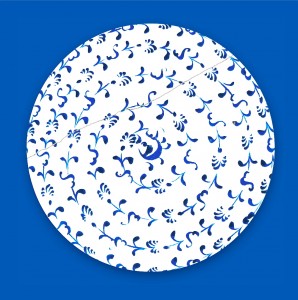 Recensione di Roberto Celada Ballanti Università di Genova
Recensione di Roberto Celada Ballanti Università di Genova
1. Dislocazioni e antinomie «Mi alzo con la mente in un punto al di sopra del pianeta e lo guardo dall’alto, come se fosse la prima volta, come quando vedo un film e mi chiedo quale è il suo messaggio. Qual è il messaggio della vita degli uomini sulla terra? Con la mente là in alto, libera dai consueti schemi mentali, nuda di fronte al mistero dell’essere, in questo momento, immagine di ogni altro momento della storia, guardo gli uomini miei simili alle prese con il mistero dell’esistenza» (p. 13)…..
Difficile, al lettore che sia familiare di cose filosofiche, di fronte a queste parole che aprono lo splendido Prologo e fanno da incipit al volume di Vito Mancuso Io e Dio. Una guida dei perplessi, non riandare a un pensatore in particolare, tra i molti altri certo possibili, ben esperto di distanziamenti e dislocazioni spaziali che, svincolando l’occhio dalla terra e dall’ineludibile limite prospettico a cui ciascuno è costretto, consentono uno sguardo scevro da pregiudizi, uno sguardo “ingenuo” o “candido”, oltre che esteso al tutto. Alludo a Voltaire e, innanzitutto, a Micromégas, il gigante di Sirio che, col suo occhio disincantato, proveniente da altrove, cifra della vera coscienza filosofica, scopre nel suo girovagare per l’universo un uomo-insetto che si agita su un mucchietto di fango, sorprendendone, un po’ come accade nell’exemplum fictum di Mancuso, antinomie laceranti, contrasti insanabili: tanto bramoso – quell’uomo-insetto – di esorbitare dai propri limiti, tanto intollerante, passionale, quanto mirabilmente capace di conoscenze. Ma la memoria va anche al Trattato di Metafisica voltairiano, dominato com’è, nel primo capitolo, da un affine distanziamento ottico, certo ispirato a Locke, che, nell’immaginarsi discendente dall’alto, rende possibile uno sguardo che abbracci simultaneamente i più vasti orizzonti e sia libero da anticipazioni e precomprensioni, antipode in ciò dell’occhiuta sorveglianza del Panopticon di Bentham.
Sgomenta, quella simultaneità ottica, spaura l’effetto d’insieme, incanta il formicolìo globale contemplato dall’alto, perché sospende la fila indiana del “prima” e del “poi” che segna la visione prospettica di ognuno, legato com’è al proprio punto di vista e immerso nel flusso eracliteo della vita: si tratta di quell’ante e di quel post con cui normalmente ordiniamo gli eventi, nostri e attorno a noi, nella speranza che si dia, in tale ordinata sequenza, un qualche progresso, un qualche significato che ci leghi alla terra. Nella simultaneità, nella compresenza ottica, è come se quell’ordine fosse congedato e sospeso a un presente che ripete, pur nella varietà infinita, la medesima vicenda («in questo momento, immagine di ogni altro momento della storia», scrive Mancuso): viene in mente il presente di Qohelet, dove «nihil sub sole novi» e dove domina la suprema tentazione della «vanitas vanitatum», del niente di senso. Lo stesso che muove allo sgomentante me phynai di Sileno, lo stesso che pone domande radicali sulla Würdigkeit dell’universo, sulla sua dignità a esistere: perché l’essere di ciò che è piuttosto che il nulla, se il mondo esibisce una tale sequenza senza fine di contrasti, di antinomie, di disuguaglianze tra i destini umani, in cui non si dà apparente senso? Perché tanto bene e tanto male distribuiti a capriccio?Così, si potrebbe dire, nelle pagine del Prologo, all’ascensus corrisponde un descensus: all’ascesa verso lo spazio dislocato sopra la terra corrisponde una discesa al cuore dell’esperienza umana. La finzione di quell’elevamento a questo vale: a sprofondare, emendato lo sguardo, sospesa l’ovvietà della quotidianità media, nell’intimo dell’umano esperire. Come nel Faust, nella parola di Mefistofele, si potrebbe dire, sprofondare e salire alle Madri sono il medesimo.
Anche la “sfilata” di beni e di mali, affastellata in sequenza casuale da Mancuso nelle pagine dell’ouverture mi ha ricordato immediatamente tante pagine di Voltaire, dove con sottile, lucida strategia speculativa, il filosofo delle Lumières, ossessionato dal problema del male e della teodicea come pochi altri nel suo secolo, opponeva alla serie regolata delle connessioni armoniche delle teodicee speculative, dove il male si converte sempre in un più alto bene, l’affastellarsi senza senso delle miserie umane, l’elencazione degli abomini, la sequenza degli orrori, incapaci di ricomporsi in un qualche ordito provvidenziale, in una qualche divina, armonica concertazione. A che i morti del terremoto di Lisbona? Perché Lisbona giace inabissata mentre a Parigi si danza? A che il massacro di ugonotti nella notte di S. Bartolomeo che ancora, a distanza di due secoli, faceva tremare, nel ricordo, la penna in mano all’anziano filosofo? A che le paradossali vicissitudini di Zadig o Candide?
Che il mondo sia come il «giardino» di Leopardi, dove sotto l’apparente bellezza dei fiori, sotto l’armonia delle aiuole, si cela la sofferenza degli steli mozzati o calpestati con noncuranza, dei frutti colti, degli sterpi tagliati brutalmente? Dove, come recita un celebre pensiero dello Zibaldone, che invita a entrare in quel giardino non delle delizie, antipode dell’Eden, «tutto è male»? Eppure, rifletto con Mancuso, nel mondo c’è bellezza, amore, bene. Essi sono là, altrettanto evidenti, a confliggere enigmaticamente con la disuguale distribuzione di beni e mali tra gli uomini, col male radicale e irredimibile per bona voluntas. A lacerare l’uomo pensoso di fronte a simile enigma tra esecrazione, lotta, abbandono al mistero. Si tratta dell’esperienza che faceva dire a Eugène Ionesco:
«Per tutta la vita ho avuto l’impressione che il mondo fosse allo stesso tempo miracoloso, stupendo, stupefacente e orribile» (Id., La ricerca di Dio. Intervista di G. Ferrari, Milano- Bellinzona 1990, p. 14).
Ma proprio qui si apre un primo, radicale punto di riflessione del libro.
2. Alle radici del religioso: la vita come domanda, Dio come domanda
Proprio da tale esperienza originaria, legata alle incomponibili antinomie e lacerazioni che la structura mondi esibisce, muove la riflessione di Mancuso sulla religione. La religione ha intimamente a che fare con quelle antinomie. Che è come dire che essa ha a che fare con la radice stessa della vita. Siamo qui – ed è il primo punto rilevante che mette conto sottolineare del volume di Mancuso – nel centro di un pensiero essenziale, di un respiro e di un orizzonte che sottrae la religione all’abbraccio soffocante di teologie confessionali e Chiese per restituirlo allo spazio aperto (“laico”) della vita e del mondo. La religione, in tale direzione, si potrebbe dire con Paul Tillich, autore caro a Mancuso, è l’interesse supremo,
lo stato di chi è afferrato da qualcosa di incondizionato, di assoluto. Oppure, si fa sentire come una sorta di appercezione mai isolata, mai relegabile in una sfera, mescolata a ogni nostro più comune percepire, come un cantus firmus che accompagna la vita quotidiana alla stregua di sottofondo, spesso reso silente o non udibile dal frastuono di quella. Come tale, entro questa visione anti-intellettualistica, la religione è situata nel cuore della vita, legata alle sue antinomie strutturali e alla domanda di trascenderle verso una qualche soteria. Tillich direbbe: la religione si colloca al centro della cultura, che va ripensata teonomicamente: «La religione è la sostanza della cultura e la cultura è la forma della religione», recita il suo celebre assioma. La «teonomia» si attua quando la religione cessa di essere una sfera specifica e diventa l’intima sostanza e la costitutiva struttura dell’esistenza: «Tutto è secolare e ogni cosa secolare è potenzialmente religiosa», osserva Tillich ne L’era protestante.
Così, in analoga prospettiva, Mancuso può sostenere l’unità di religione e mondo, di religione e cultura, affermando che il «ritorno di Dio» (ammesso che l’espressione abbia senso o che, piuttosto, non si debba dire che Dio non ritorna perché non se ne è mai andato), ossia la rinascita religiosa in atto da diversi decenni, non è capace «di interpretare il mondo reale e per questo non sa produrre cultura» (p. 35), e che «una religione senza cultura è una civiltà senza religione» (p. 37).
Declinata, per i processi di secolarizzazione moderni, la forza coesiva delle religioni storiche e, più di recente, la spinta delle religioni laiciste delle ideologie, che delle prime sono state le eredi, domina la fase della modernità toccataci in sorte, segnata da una radicale insecuritas, da un lato il «Mostro mite» (lo dico con sintagma preso a prestito da un illuminante pamphlet di Raffaele Simone, così intitolato) del nichilismo aziendalista e neo- liberista, dall’altro, speculare a questo, una religiosità dell’immediato, del “fai da te”, che fissa oggetti rassicuranti, spicciole regole consolatorie, a cui ci hanno abituati le attuali metamorfosi di Dio, con l’efflorescenza che le segna: dalla variegata galassia della New Age, coi suoi trasalimenti spiritualistici di inizio millennio, ai letteralismi fondamentalistici d’assalto.
Ma il religioso, nella sua autenticità, non si identifica con la congerie di fedi irrazionali, attese messianiche, arcaismi postmoderni, demonologie, miti fantascientifici, esoterismi da supermarket, che vediamo fare pendant alle distrazioni narcotico-edonistiche che il mercato a piene mani propala, e neppure coincide con le ortodossie. Il religioso, all’origine, come Mancuso richiama, è domanda, è l’interrogare di Giobbe, l’interrogare di Cristo sulla croce. E, proprio a causa delle metamorfosi subite nel corso della modernità, quel religioso, nella sua purità ultima, lo si rinviene lontanissimo, spesso, dai sistemi di amministrazione del sacro e di offerta soterica. Una religione – questo si intende dire, assecondando la visione di Mancuso – che non muova dal problema umano nella sua struttura costitutiva è risposta a una domanda che non si pone, come suggerisce l’icastico episodio della metropolitana di New York ripreso dall’autobiografia di Norberto Bobbio (p. 24). E nulla è più insensato di una risposta a una domanda che non si pone.
Terribile e miracoloso, tremendum et fascinans: così appare, dunque, l’irriducibile antinomia che segna l’esperienza elementare dell’uomo che viene a questo mondo. Non è qui forse l’origine del Sacro, così come Rudolf Otto l’ha descritta nella sua classica opera del 1917, ripresa e commentata da Mancuso? (pp. 54 ss.) Ma, se certo lo stupore religioso è
altra cosa dalla filosofica meraviglia da cui per Platone e Aristotele nasce la filosofia, simile stupore, per cui siamo di fronte alla Trascendenza in posizione di sgomento, terrore, o di invocazione, contemplazione, precede non solo la riflessione teoretica, ma anche l’etica: «La vita – come osserva Mancuso – viene molto prima della morale» (p. 55).
Pure, se nel Sacro l’uomo coglie il senso dell’essere come legato alla Trascendenza, la legge strutturale che egli avverte penetrare sé e il cosmo, come esigenza apriori, inscalfibile, è la legge del bene, ciò che propizia la progressiva emendatio dal Sacro autoritario al Religioso, o al Santo, nel suo senso più spirituale e libero. Quel religamen che l’uomo cerca nella religio (religio come religare, certo, ma anche come relegere, ossia esaminare con cura, perciò scegliere, selezionare, ponderare, ciò che per Cicerone distingue la religio dalla superstitio) non meno che nel logos, come Mancuso mette in luce esemplarmente (pp. 60 ss.), quasi compitando, nel secondo capitolo, la struttura costitutiva dell’esperienza religiosa e il suo lessico di base, quasi riformulandone la grammatica essenziale; quel legame – dicevo – ricercato nella religione quanto nella filosofia come Logos che, platonicamente, tiene sul caos, sul non-senso, deve (soll) essere filtrato da quella legge del bene avvertita operante nella propria coscienza.
Una riflessione religiosa dunque che, mossa dalla domanda de vera fide e de vera ecclesia intenda riandare alle sorgenti del religioso non può, in questa prospettiva, che scoprirle nell’inscindibile nesso che esse mostrano con l’etico e la legge che lo domina, quella del summum bonum. Lo sapeva, prima di Kant, Platone che, nello svolgere nel Libro II della Repubblica, rispetto alla tradizione mitica, un processo di demitizzazione, proprio al principio etico ispira tale emendatio, nella stessa pagina in cui si incontra per la prima volta la parola «theologhia», significativamente intrecciata, sin da tale origine, a problemi di teodicea (Dio causa dei soli beni e non dei mali; Dio immutabile, perciò non ingannatore: Resp. II 379 a ss.). Si tratta di un punto-chiave della visione teologica di Mancuso – quello del rapporto tra l’etico e il religioso - e di un nodo cruciale del libro che occorrerà riprendere oltre.
È un grande pregio del libro di Mancuso, tra gli altri, come dicevo, quello di istituire una rifondazione del religioso muovendo dalla domanda umana radicale, ponendo una propedeutica esperienziale del religioso, in un tempo in cui analfabetismo e imbarbarimento del sentire, soprattutto tra i giovani, hanno prodotto l’oblìo di una grammatica elementare dell’umano capace di nominare i grandi interrogativi dell’esistenza, radicalizzandone l’orizzonte, tenendoli all’altezza di ciò che esigono senza rinserrarli, prima ancora che vengano posti, nel perimetro delle risposte preconfezionate dall’industria culturale e della religione dei consumi.
«Di quale domanda Dio è la risposta?», chiede Mancuso (p. 40). Questo è, nel dominio religioso, l’ineludibile punto di partenza teologico, filosofico, pedagogico, culturale, oggi. Come ha scritto il sociologo Peter L. Berger, la modernità, pluralizzando, relativizzando, moltiplicando le offerte di senso, sospende l’ovvio, congeda il “dato per scontato”, e oggi nulla nel problema religioso può essere dato per scontato. La «perplessità» cui il titolo del libro fa riferimento, nel riecheggiare la Guida dei perplessi di Maimonide, è in tal senso l’approdo più problematico, ma anche più fecondo, della modernità. Per questo, dice ancora Berger, la teologia, per dirsi all’altezza del proprio tempo, dovrà privilegiare il “metodo
induttivo”, esperienziale, movente “dal basso”, la cui più esemplare esecuzione appaiono a Berger i Discorsi sulla religione di Schleiermacher – dove tra l’altro, in modo affine a Mancuso, nelle pagine della prima Rede, il religioso coincide col respiro stesso della vita, con la tensione all’infinito dello spirito risultante dalla sistole/diastole del moto vivente di attrazione/espansione -, rispetto al “metodo deduttivo”, ortodosso, che parte dall’alto di rivelazioni, dogmi e dottrine per giungere, se mai vi giunge, all’uomo e al suo vissuto (cfr. P.L. Berger, L’imperativo eretico. Possibilità contemporanee di affermazione religiosa, tr. it. Leumann-Torino 1987). Scrive Mancuso in analoga direzione:
«Descrivere la realtà per quello che è, fetori e marcescenze comprese; onestà intellettuale, disincanto, aderenza alla vita concreta senza evaderne in cerca di consolazioni a buon mercato […]. Io penso che la teologia cristiana abbia bisogno di empirismo, di fedeltà all’esperienza reale» (p. 135).
La vita come domanda, Dio stesso come domanda (pp. 399 ss.): in fondo – è pensiero che da tempo vengo coltivando quale inconsapevole collocutore dell’autore – se l’uomo è definito da una capacità di domandare e di ricevere più o meno grande, più o meno capiente (quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur, recita un assioma scolastico), e se Dio c’è, Egli è Dio essenzialmente perché in Lui la ricettività è infinita, perché possiede una domanda infinitamente grande, capiente, perché il “senso religioso” in Lui è in grado massimo. Senza essere scavato nella domanda, nel grido, Dio resta flatus vocis. Giobbe conosce Dio solo nel grido, solo impigliato, e implicato, nel suo domandare: «Ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (Gb, 42, 5). Solo in quanto scavato nel grido, Giobbe «vede» Dio. Giobbe è Dio come domanda. Questa è, kantianamente, la sua «Aufrichtigkeit», la sua «sincerità». La stessa richiamata da Albert Schweitzer in un testo ricordato nel volume: «La sincerità è il fondamento della vita spirituale» (p. 198).
3. «Non è la Chiesa», «non è la Storia»: modernità, religione, laicità
Il titolo del libro, Io e Dio, nomina la diade essenziale che il processo ermeneutico rinviene laddove restituisca la religione alle sue archai, ai suoi Ursprünge, alle sue strutture costitutive, a quel punto di fioritura cui occorre sempre riandare, per imbeversi della sua linfa originaria, dopo che il fuoco dell’ispirazione si sia fissato, cristallizzato, com’è destino, in parola, forma, dottrina. Ancora con Tillich, si potrebbe indicare la dialettica intrinseca al religioso come l’intima “protesta” che da esso si leva dopo che la religione si sia congelata in forme troppo anguste, asfittiche. Mancuso, si direbbe, dà voce esemplarmente al «principio protestante» di Tillich, ossia alla tensione dialettica per cui la religione, una religione storica, è sospinta a trascendersi in direzione di ciò che la supera.
Categorizzando in forma filosofica il principio protestante, si potrebbe parlare, a mio avviso, di principio trascendentale religioso, che agisce come moto di ulteriorità e di trascendenza dentro le concrezioni storiche, così da sollecitarle a una perenne novitas spiritus. Vale, in tal senso, che per essere vitale una religione deve accogliere quanto nega le oggettivazioni dottrinali, chiesastiche, come se l’incondizionato in essa operante si
levasse a spezzare le chiusure che ne soffocano lo spirito rinserrandone la pulsazione vitale. Una religione che emargini, perseguiti, come troppe volte è accaduto nella storia delle Chiese, chi dà voce a tale dimensione di ulteriorità, di protesta, è condannata alla sterilità di un’estenuata routine ecclesiastica, di potere o devozionale. È condannata, nel farsi «mausoleo della religione», per dirla con Schleiermacher, museale deposito di uno spirito che non c’è più perché migrato altrove, a quello «scisma (non più) sommerso» di cui Mancuso tratta nel richiamarsi al noto pamphlet di Pietro Prini (p. 374 ss.).
Per questo l’uomo di oggi, non irreligioso ma aporeticamente religioso, problematicamente religioso, appare per lo più indifferente alle esposizioni teologiche o del Magistero che cristallizzano la fede in forme incapaci di parlargli in modo esistenzialmente vivo delle questioni destinali. Avvilendo la profondità della parola biblica nell’aridità di un linguaggio in cui poco filtra della luce dell’esistentività, della poieticità, dell’ispirazione religiosa autentica, in tali esposizioni non si avverte più che una debole eco di quel baudelairiano «ardent sanglot qui roule d’âge en âge, et vient mourir au bord de votre éternité» (Les Phares), che rappresenta il presupposto e il fine di ogni teologia degna del nome. Si tratta di quell’ardent sanglot che avverto pulsare da cima a fondo nel libro di Mancuso, sotto forma di domanda, di protesta, di ricerca inquieta, e in tanti altri suoi lavori.
Quando si rifiuti la diagnosi del mondo contemporaneo come mondo desacralizzato e se ne colga, invece, la lacerata religiosità, spesso esperita in forme tragiche, il rapporto tra cristianesimo e mondo contemporaneo muta radicalmente, almeno quanto la valutazione della modernità e dei processi di secolarizzazione. Così, ad esempio, diviene evidente che “secolarizzazione” non equivale a fine del religioso ma a una sua trasformazione, e che i processi secolarizzanti, prima che traslare beni materiali, proprietà religiose in mani secolari, hanno spostato un bene di altra natura, più invisibile, più recondito, ma anche più essenziale: si tratta dell’identità profonda delle religioni, che da quella traslazione escono destrutturate, impoverite quanto a incidenza politica, sociale, educativa, trasformate in profondità, ma non scomparse dall’orizzonte umano, anzi, proprio all’opposto, rilegittimate, addirittura sollecitate a riattingere con maggiore purità le proprie strutture costitutive, esistenziali e storiche.
La secolarizzazione corrisponde, come origine, come mi è accaduto altrove di scrivere, a un esodo di un “primo bene” che, anteriormente ai beni materiali, è migrato dalle Chiese: si tratta della domanda religiosa, del senso religioso, che non si identifica più nei sistemi di amministrazione soterica tradizionali. Nella divaricazione tra domanda e offerta, nel migrare della domanda dai sistemi di amministrazione dell’offerta (in primis le istituzioni ecclesiali) sta il nucleo “sommerso” della secolarizzazione. L’età moderna – osando tentarne una caratterizzazione di fondo – potrebbe essere letta come l’età della cesura tra domanda di senso e sistemi tradizionali di offerta religiosa, con il tempo della “migrazione” (“secolarizzazione”) della prima dai secondi. Dove esodo da istituzioni e teologie equivale altresì a categorizzazione autonoma della religione, la quale, proprio in virtù di tale autonomia, non si identifica più tout court con la fides christiana, ma finisce per definire uno spazio plurale, “trascendentale”, perciò “laico”.
Dipende da tale “migrazione” se il religioso, a partire dalla modernità, anziché alla strutturazione di spazi civili o sociali o alla forza integratrice di un ethos condiviso, allude a
un’adesione volontaria a una fede o, per dirla con Ulrich Beck, a un «Dio personale», lui stesso migrato dalle istituzioni. Primato della fides qua creditur sulla fides quae creditur significa primato dell’autenticità sulla conformità, coincidendo, tale torsione, tale mutamento, con quel «gigantesco spostamento dal destino alla scelta nella condizione umana» in cui Berger ha colto il tratto qualificante della modernità, posta, in tal senso, sotto il sigillo di un peculiare sintagma: l’obbligo della scelta (hairesis), ossia l’«imperativo eretico».
Per tutto questo, per riecheggiare nuovamente Tillich, sembra che la prima parola che la religione deve dire agli uomini del nostro tempo sia una parola contro la religione. Ecco perché la pars destruens appare densamente presente nel discorso teologico di Mancuso: «non è la Chiesa», «non è la storia». Non è il principio di autorità che domina, come l’autore denuncia già nelle prime battute del libro, l’impostazione cattolica ufficiale, nella quale la dimensione oggettiva-dottrinale fonda l’adesione del credente. La teologia, per l’autore, ha questa primaria funzione: sgomberare il campo, emendare, schiudere gli spazi affinché il problema di Dio, e dell’Io, possa essere affrontato in novitate et libertate spiritus, ponendo la teologia sotto il sigillo del principio della libertà invece che di quello eteronomo di autorità (cfr. l’intero capitolo VIII). Si tratta di una svolta radicale e gravida di conseguenze:
«In questo libro – avverte l’autore – io difendo la libertà, che è il concetto decisivo a essere in gioco dietro il pronome personale Io. Io e Dio avrebbe potuto intitolarsi allo stesso modo “La libertà e Dio”, perché alla fine ciò che io intendo fare con l’insieme del mio lavoro è una teologia della libertà, della libertà che si compie come amore. Questo libro difende la libertà contro la duplice minaccia dell’autoritarismo religioso e dello scientismo negatore del libero arbitrio» (p. 16).
Una conseguenza di tale capovolgimento dal principio di autorità a quello di libertà (o autenticità) – che formulo in dialogico synphilosophein con Mancuso – mi pare cruciale: una volta affrancato il discorso su Dio, la ricerca su Dio, dal principio di autorità, la teologia non finisce per rifluire nella filosofia o, quanto meno, per finire in prossimità di essa? Nell’atto in cui crollano, inverate nel soffio dell’universale rivelazione che accade in ogni uomo che viene in questo mondo, le nozioni di soprannatura, grazia, miracolo, Chiesa, nell’accezione confessionale, non viene congedato con ciò stesso il senso della teologia dogmatica, destinata a risolversi appunto nella filosofia, che da sempre, dalle sue origini, si è posta come una libera ricerca sul divino? Non è Socrate di fronte a Eutifrone – il sacerdote esponente del mito, fautore del volontarismo religioso e dell’arbitrarismo teologico eteronomo (santo è ciò che piace agli dèi) – la cifra di questa fede filosofica, sintesi di religiosità e libertà, come Nietzsche ha visto, che la modernità, almeno in una sua corrente, quella dei Bruno, degli Spinoza, dei Lessing, dei Kant, degli Schleiermacher, dei Troeltsch, degli Jaspers, delle Weil, avrebbe riattinto e riformulato?
E non è qui, nel transito dal principio di autorità al principio della libertà, il fondamento di quella «teologia laica» perseguita da Mancuso? Già ne L’anima e il suo destino, l’autore aveva scritto: «La vera laicità significa ritenere conclusivo non il principio di autorità ma la luce della coscienza». La laicità non concerne solo la sfera politica, ma il rapporto dell’uomo
con la verità: Socrate contro Eutifrone, appunto (e sul «Dilemma di Eutifrone» torneremo oltre). Nell’incapacità, che non è “innocente” ma ha una precisa “genealogia”, di pensare Dio e le grandi questioni destinali, di elaborare il discorso teologico laicamente, sta uno dei punti-chiave della crisi religiosa del nostro tempo: ciò che ha allontanato, e continua a tenere lontane, tante coscienze da quei domìni, che odorano troppo di sagrestia per occuparsene da laici, in modo pro-fano, fuori dal fanum, dove stava Gesù, o sull’agora, dove Socrate curava le anime. Ripensare la grammatica di una religio laici è un compito immane del nostro tempo. E a questo compito Mancuso reca un rilevante apporto.
Jaspers, nel dibattito con Bultmann sulla demitizzazione, esprimeva così l’idea della risoluzione della teologia confessionale nella filosofia, adunando in essa il principio stesso della Liberalität religiosa, ossia quello della libertà applicato al dominio del religioso, in opposizione alla Orthodoxie del grande teologo protestante:
«Nella Liberalität - scrive Jaspers – lo sviluppo naturale […] sembra costituito dall’incontro tra teologia e filosofia, dal fatto che esse, forse, possano alla fine unirsi di nuovo, com’erano unite in Platone, negli Stoici, in Origene, in Agostino, in Cusano. Se ciò dovesse accadere, si dovrebbe operare questa distinzione: teologia e filosofia possono unificarsi, ma non religione e filosofia. Nella religione scorre la sorgente della realtà, non raggiungibile né fondabile dalla filosofia, attraverso la comunità e nella relazione ai luoghi sacri, alle azioni, agli oggetti, ai libri, mediante il culto e la preghiera, l’ufficio del sacerdote, in breve mediante la corporeità delle cifre. Qui la filosofia cede e leva lo sguardo oltre se stessa» (K. Jaspers – R. Bultmann, Il problema della demitizzazione, tr. it. Brescia 1995, p. 124).
Discendono, nella stessa direzione, il dissolversi di un’idea di Chiesa garante di una verità e di una salvezza “riservate” ai credenti e l’istanza di ripensare il senso ultimo della comunità religiosa. Si è condotti, per questa via, a un’acuta problematizzazione dell’immagine delle Chiese storiche, che investe il luogo e la forma del rivelarsi della verità e finisce per concernere la posizione del credente nella comunità: è questi chiamato all’obbedienza a una verità data o dispiegantesi nei modi che l’autorità conferma, garantisce e amministra, o è sollecitato, nel proprio itinerario religioso, a una libertà in senso innovante e ricercante?
4. Una “terza via” nel dominio teologico-religioso
In questo senso, per restare alla pars destruens, vedo nel lavoro teologico di Mancuso, e nel libro in questione, un vasto lavoro di emendatio che mi appare, per tanti versi, il portato più maturo di una certa modernità, quella che, evidentemente, ad avviso del teologo, e anche di chi scrive, è rimasta impensata e ancora nuovamente da pensare. Si tratta della modernità propria di una terza via nel dominio religioso, collocata nella scomoda posizione di medietà tra le ortodossie confessionali, da un lato, e le correnti ateistiche, dall’altro. Terza via che la modernità ha dischiuso come possibilità ma che è rimasta, a causa della persecuzione e della condanna cui è stata sottoposta dalle Chiese europee, un progetto schiacciato nella morsa dell’esclusivismo confessionale e della critica radicale della religione.
Se «moderno» equivale a «nato da poco» (quasi modo nati), se il «modo» di modernus allude all’ora, all’adesso, al tempo presente, è perché, con esso, si intendeva respingere, da parte dell’homo che di quel modernus si è fatto interprete, dall’Umanesimo-Rinascimento il poi, una certa forma di pensare la verità: quella legata alla storia, all’origine, al traditum, all’autorità di chi di quell’origine, di quella storia salvifica, di quel traditum, di quella parola, si ergeva a interprete e depositario esclusivo. È in nome di un altro modo di pensare la verità che l’uomo moderno cerca un fondamento che non stia più nell’autorità di quel passato, di quella origine, sia una Chiesa, una Scrittura, un dogma. Perciò, neppure il deposito della Rivelazione amministrato dalla Chiesa e custodito nei Libri sacri, neppure ciò che è stato rivelato in origine come verità eterna, può andare esente da scepsi e ricerca. Sta qui l’inizio, dall’età di Erasmo, dell’applicazione della filologia alle Sacre Scritture e del metodo storico-critico, sta qui, da Reimarus in poi, la nascita della questione del Gesù storico, esemplarmente sintetizzata da Mancuso nel capitolo VII.
Ora, a voler essere brachilogici, la modernità, con buona pace di Barth e Blumenberg, per limitarmi a due nomi significativamente appartenenti a due ambiti di pensiero diversissimi, eppure solidali nella lettura del moderno, non è stata solo ortodossie autoritarie e ateismo: mentre l’ecumene religiosa europea si dissolveva nel caos dei conflitti, delle Guerre di religione, mentre la «sommersa nave de la religion», come scrive Giordano Bruno nello Spaccio de la bestia trionfante, inabissandosi, faceva affiorare tavole, relitti, i resti incomponibili di quella religione storica, si rafforzava una coscienza tesa a riattingere, del rapporto col divino, le vere sorgenti. Da Cusano a Erasmo, dagli Spiritualisti mistici del Cinquecento come Sebastian Franck, Sébastien Castellion a Herbert di Cherbury, da Bruno a Spinoza, da Voltaire a Rousseau, da Lessing a Kant, da Schleiermacher a Troeltsch, da Tillich a Schweitzer, da Weil a Jaspers, mi sembra possibile ricostruire una vera e propria linea di pensiero che, per quanto non classificabile né adunabile attorno a una dottrina, a un programma, a una corrente cronologicamente circoscrivibile, è cementata da un’idea, da un principio di fondo: il principio – per eccellenza moderno – per cui il rivelarsi della verità etico-soterica non è identificabile in una ecclesia visibilis, in un’autorità esterna garante di un evento salvifico, né in un testo sacro, ma è attingibile in libertate singuli, nella rivelazione che, in grazia di un lumen Dei, si compie nella coscienza, pur da concepirsi come radicata in un traditum storico e dotata di vocazione ecclesiale. Il singolo, nell’atto in cui intravede la verità, in timore e tremore, cosciente che la voce della coscienza non coincide con la voce di Dio, nello sforzo di sceverare l’autentico dall’inautentico è, per quel principio, per quel lume, il luogo dove Dio “parla” e insieme il criterio, la norma, per il riconoscimento della religione autentica.
Accomunate e rese solidali dall’emarginazione e dalla persecuzione delle Chiese, queste forze spirituali indipendenti hanno cospirato, nel dominio del religioso, a un fermento consumativo, a una vera emendatio del religioso: a quel logoramento del letteralismo, delle superstizioni, che dello “spirito” sono il soffocamento e l’atrofia. Si tratta, appunto, di quei processi che il volume di Mancuso, nei capitoli VI (Non è la Chiesa) e VII (Non è la storia), con erudizione pari a limpidezza espositiva, aduna e compendia. In quei capitoli, come in quello dedicato alla critica del principio di autorità (capitolo VIII), riconosco l’eredità moderna più feconda della corrente filosofico-teologica prima sinteticamente
additata, che ho ricostruito nel mio studio Pensiero religioso liberale. Lineamenti, figure, prospettive (Brescia 2009). L’Illuminismo, in primis tedesco, ha in questo senso rappresentato, per taluni aspetti, un processo decostruttivo, demitizzante, un metodo e una propedeutica all’inverarsi in senso spirituale e trascendentale della religione.
È quanto Lessing, pensatore giustamente assai presente nella riflessione di Mancuso, negli scritti legati al Fragmentenstreit, alla celebre disputa sui Frammenti di Reimarus, esprimeva nei termini della liberazione della verità «interna» della religione dalla sua verità «ermeneutica», legata alla prigionìa della storia e catturata nella ragnatela fragile delle prove storiche. Questo, del resto, addita con mirabile forza poetica e pedagogica Nathan il saggio: l’attingimento dell’universalmente umano nel dominio religioso, che supera la violenza delle logiche identitarie, lo stesso rivelarsi di Dio, passano per la vicenda dei singoli, per la loro libertà, per quelle “linee curve” della storia che solo alla fine sciolgono l’enigma del loro intreccio nello stupore di un disegno sapiente e mirabile. Così, il liquefarsi delle concrezioni identitarie – ma non della storicità delle religioni – nel Nathan, propizia alla fine il venire alla luce di un intreccio, di un’armonia occulta, nella forma della famiglia, della parentela, di una ecclesia ecumenica che giaceva occultata sotto quelle rigidità e attendeva di venire alla luce.
In ciò vedo una figura possibile di quel «cristianesimo dialogico» che Mancuso addita come il nucleo della sua proposta “positiva”, versus il «cristianesimo identitario», che «identifica la verità del mondo e della vita con la propria identità, da intendersi come dottrina garantita dal Magistero pontificio […]» (p. 439). Non a caso Mancuso pone il transito dalla seconda immagine del cristianesimo alla prima, dialogica, sotto il segno dell’Antitesi di Lessing, variante moderna e illuminista dell’antico socratico «Dilemma di Eutifrone», enunciata poco prima nel libro (p. 438):
«La religione non è vera perché gli evangelisti e gli apostoli la insegnarono; ma essi la insegnarono perché è vera».
Non a caso, si diceva, perché a fare da spartiacque tra quelle due figure del cristianesimo, tra quelle due ermeneutiche dell’esperire religioso, il cui contrasto non è nuovo perché innerva e tormenta, in realtà, l’intera storia del cristianesimo, sta un’autentica rivoluzione copernicana nel dominio del religioso che considero uno dei centri focali del volume e della proposta filosofico-teologica di Mancuso.
5. «Il mio Dio». L’Antitesi di Lessing e la rivoluzione copernicana nel dominio del religioso
Se – in ciò insicuro di assecondare l’intenzione autorale, che del resto non è per me la Grundnorm dell’ermeneutica – dovessi indicare un centro ideale, additare un fuoco “trascendentale”, per così dire, del libro, là dove si aduna la pars construens della sua proposta teoretica e teologica, lo indicherei nel capitolo quinto (Il mio Dio). Il cui punto- chiave consiste in una meditazione dell’episodio biblico di Genesi 22, ossia del sacrificio di Isacco. A fare da spunto sta il racconto di un’esperienza personale dell’autore, un bel dialogo tra lui e i suoi figli a quella scena biblica ispirato: «Papà, ma se Dio ti ordina di
uccidermi, tu mi uccidi?» (p. 174). Senza esitazione è la replica paterna: «No Caterina, non se ne parla nemmeno. Se Dio mi dovesse ordinare una cosa del genere, gli direi di no».
Tra il Kierkegaard di Timore e tremore, per cui Abramo è il «Cavaliere della fede» che, nella solitudine più abissale, trascende l’Etica e il Generale per accedere all’assolutezza singolare del rapporto con Dio, dove quell’Etica è sospesa, e il Kant del Conflitto delle facoltà, per il quale una voce udita nella coscienza che comandasse il sacrificio del figlio non sarebbe certo la voce di Dio ma, per dirla con Cartesio, di un Genio ingannatore, Mancuso non ha dubbi:
«Se la risposta è Kierkegaard, io quella mattina ho sbagliato a rispondere a mia figlia nel modo in cui ho fatto […]. Se la risposta invece è Kant, io quella mattina non ho sbagliato» (pp. 179-180).
Kierkegaard o Kant? Qual è la Sache selbst in gioco qui? Le riflessioni di queste pagine, che innervano come un fiume carsico l’intero volume, consentono di cogliere quel che “ne va” nella res in questione. Anche su questo punto, per me essenziale, vorrei dialogare e co-meditare con l’autore del libro, nella certezza che un testo diviene vivo, fecondo, parlante, solo nell’assimilazione e trasformazione ermeneutica (Aneignung- Verwandlung, direbbe Jaspers) che ne viene fatta. L’episodio di Abramo e Isacco contiene, in realtà, in una sua possibile espressione, la sostanza di un “dilemma” che anche il pensiero greco conosceva, e che segna uno dei fuochi problematici perenni dell’esperienza religiosa, che si allunga da Socrate ad Agostino, dalla teologia medievale a Grozio (etsi Deus non daretur), da Lessing a Kant, da Weil a Wittgenstein, per fare solo qualche nome, in una serie di variazioni e di “eterni ritorni” che finiscono per coinvolgere alcune delle più rilevanti questioni spirituali, etiche e religiose, del nostro tempo. Alludo al Dilemma di Eutifrone, la cui formulazione, nell’omonimo dialogo platonico suona:
«Considera questo: il santo viene amato dagli dèi in quanto è santo, oppure in quanto viene amato è santo?» (Euthyphr. 10 a).
Ed ecco la soluzione socratica, versus Eutifrone, al dilemma: «Proprio in quanto è santo, viene amato, e non, invece, in quanto viene amato, per questo
è santo» (Euthyphr. 10d).
Ora, una variante illuminista – non l’unica, ma forse la più significativa – del Dilemma di Eutifrone, insieme alla soluzione socratica, è la formula, già riferita, che Lessing ha scritto negli Axiomata, oltre che, in forma più estesa, nelle Antitesi ai Frammenti, che Mancuso riprende. Si può ben dire che la proposizione antitetica lessinghiana trasferisca la soluzione socratica al Dilemma di Eutifrone nel contesto del cristianesimo moderno, traducendo le implicazioni incluse in quel nodo. Non a caso, nel IX degli Axiomata quell’antitesi è rivolta contro il volontarismo protestante (cfr. G.E. Lessing, Religione e libertà, tr. it. Brescia 2000, p. 150).
Il “ritorno” del Dilemma di Eutifrone attesta che la res che in e per esso ne va non è stata risolta dal cristianesimo e dalle relative dottrine teologiche. Ma in cosa consiste questa res,
così cruciale? Siamo qui, come si diceva, in uno dei punti-chiave della proposta teologica di Mancuso. Per quella res - autentica “rivoluzione copernicana” nel dominio del religioso – la Parola di senso, o soterica, proveniente dal passato – mýthos o rivelazione depositata in una Scrittura o in una Chiesa – dove sia ascoltata, lo è essenzialmente per la corrispondenza alla verità che si offre al singolo nel suo presente e nella rivelazione presente che in lui si compie. Non perché amata dagli dèi, non perché scritta, canonizzata, quell’azione è santa, quella parola è vera, in nome dunque di un principio eteronomo, ma tale può dirsi solo in nome di un’istanza – giudizio o lume – indipendente e interiore che né la volontà divina né un’autorità esterna possono avocare a sé: solo, dunque, nel libero discernimento e nell’illuminazione provenienti dalla rivelazione attuale, la cui voce – si ricordi il Kant interprete del sacrificio di Isacco – è dato udire sempre con fatica, nel rischio e non senza mescolanza di impurità.
Ecco come il Kant della Critica della ragion pura riformula la posizione socratica del Dilemma di Eutifrone:
«Nella misura in cui la ragion pratica ha diritto di guidarci, noi non riterremo le azioni obbligatorie perché sono comandi di Dio, ma le considereremo comandi di Dio, perché ad essi noi ci sentiamo internamente obbligati» (Critica della ragion pura, tr. it. Roma-Bari 1985, vol. II, p. 621).
La santità della legge morale dipende dalla rivelazione contenuta nella Sacra Scrittura, oppure la Scrittura è divinamente ispirata perché contiene, attesta, conferma, la legge morale? È questo secondo corno dell’alternativa, com’è ben noto, per lo Spinoza del Tractatus theologico-politicus come per il Kant della Religione nei limiti della semplice ragione e del Conflitto delle facoltà, a essere vero. Autenticamente religiosa in quanto morale è la chiave ermeneutica per leggere la Bibbia, per entrambi. L’etico fonda il religioso, muovendo dalle antinomie e lacerazioni che si schiudono nell’esperienza. Come se dentro alla domanda quid agendum? si schiudesse il baratro di un più originario, e arrischiante, domandare: ad quid totum istud agere et agi? Così, quando Simone Weil, ripetendo a suo modo l’inversione kantiana e quella contenuta nell’antitesi di Lessing, sosteneva che
«non c’è il punto di vista cristiano e gli altri, ma la verità e l’errore. Non: ciò che non è
cristiano è falso, ma: tutto ciò che è vero è cristiano» (Quaderni, tr. it. Milano 20063, vol. III, p. 401),
non indicava, nello stesso spirito di Mancuso, la riforma più urgente del cristianesimo, la condizione ineludibile per acquisire la sua cattolicità, per esercitare la sua missione, fuori dalla quale esistono solo divisioni, conflitti, divorzi tra culture e religioni?
La via all’universalismo, alla pace, all’unità, al cristianesimo dialogico, passa per quell’inversione, per quella rivoluzione copernicana, che implica, quasi rispecchiasse l’evangelico chicco di grano che deve morire per portare frutto (Gv 12, 24), la rinuncia da parte di religioni e Chiese alla logica identitaria fondata sul potere, sull’amministrazione della salvezza, in vista di un’identità più intima, più segreta, che unisce religioni, culture e
civiltà, poiché sottesa a ognuna di esse e già operante nel profondo. È, in realtà, la legge della kenosis e dell’agape a guidare segretamente l’antitesi di
Lessing. Scorporare la verità del cristianesimo dalla cronologia, sottrarla alla fragile “ragnatela” delle prove storiche, come diceva Lessing, appare alla Weil la via mediante cui il cristianesimo può farsi universale senza essere totalitario:
«Perché il cristianesimo s’incarni veramente – scrive la pensatrice francese nella Lettera a un religioso -, perché l’ispirazione cristiana impregni per intero la vita, bisogna innanzitutto riconoscere che storicamente la nostra civiltà profana procede da una ispirazione religiosa che, sebbene in ordine cronologico precristiana, era cristiana nella sua essenza. La Saggezza di Dio deve essere considerata l’unica fonte di ogni luce quaggiù, anche dei lumi così fievoli che rischiarano le cose di questo mondo» (Lettera a un religioso, tr. it. Milano 1996, p. 22).
Tale è la «verità interna» che anche Mancuso richiama:
«cioè tale che anche un uomo su un’isola deserta potrebbe avvertirla, tale che anche i miliardi di uomini che non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo e meno che mai della Chiesa cattolica, possano avvertirla e praticarla» (p. 438).
Parole che potrebbero appartenere, e di fatto appartengono come spirito, prima che alla Weil, a Sebastian Franck:
«poiché Dio non distingue tra gli uomini, ma è presente ai greci come ai barbari e ai turchi, ai signori e ai servi, in quanto essi conservino la luce che è stata impressa in loro e che dona ai loro cuori un lume eterno» (Lettera a Campanus, in Quellen zur Geschichte der Täufer, VII. Band, Elsaß, I. Teil, Stadt Straßburg 1522-1532, Gütersloh 1959, p. 306).
6. Una misura comune: tra Socrate e Giobbe
Ancora qualche riflessione mi sia concessa, nel solco del mio dialogo con l’autore del libro, il consenso di fondo col quale è, per quanto sono venuto sin qui dicendo, sin troppo esplicito per dovervi ulteriormente insistere. Che strano “Dio” quello di Socrate che, come si legge nell’Apologia platonica, comanda all’uomo di filosofare, ossia di essere libero e critico, anche nei confronti della parola dell’Oracolo di Delfi:
«E a me questo [il filosofare], come ancora vi dico, è stato comandato dal dio, con oracoli e con sogni e in tutti quei modi con cui, talora, anche in altri casi, il destino divino comanda all’uomo di compiere una certa cosa» (Apologia, 33 C).
Se tra l’imperativo di filosofare, di seguire il ragionamento ovunque esso possa condurre, e l’obbedienza ai segni divini, soprannaturali, Socrate non avverte conflitto, è perché entrambi – legge del logos e legge della parola rivelata – promanano dalla stessa fonte. Mancuso, nella sua riflessione, insiste molto su una simile identità. Cogliere cosa sia questa fonte equivale a svelare il nesso, in Socrate, tra religiosità e libertà.
In realtà, se il Dio comanda all’uomo la ricerca, se gli chiede di farsi co-ricercante, è perché dietro quel comando c’è il continuum di un patto - di un religamen - che
ontologicamente vincola dèi e uomini: per esso, verità, giustizia, bene, santità, hanno una comune forza normativa, e se un uomo buono non può nuocere ad alcuno, a fortiori neppure Dio può farlo. Per dirla con Kant, quei valori non si limitano agli uomini ma coinvolgono «l’Essere infinito, come intelligenza suprema» (Critica della ragion pratica, tr. it. Milano 1988, p. 216).
È dunque per quel vincolo, per quel continuum, che Socrate può rivisitare l’Oracolo di Delfi interiorizzandolo, rispecchiandone la voce nella potenza demonica che avvertiva in sé, orientando destino e destinazione dell’uomo. La rivoluzione religiosa con cui Socrate invera il luogo più celebrato della religiosità greca traducendolo in un luogo dell’anima, presuppone quella prossimità, quella misura comune tra dèi e uomini, vincolati alla normatività di quei valori. Per questo la condotta umana possiede valore indipendente dalla giustizia retributiva divina e dalla sua eziologia (tanto il lavoro, così il compenso). E per questo l’ascolto di quella voce non muove all’obbedienza supina, come in Eutifrone, ma apre lo spazio del colloquio o del conflitto con il divino.
Conflitto col divino: anche Giobbe, l’uomo che lotta con Dio, non spezza né tradisce mai il vincolo della pietà, il religamen , non mette in dubbio che Dio sia Padre, eppure impreca, grida, chiede a Dio di rivelarsi come Padre, ossia di non smentire se stesso. Anche nel Libro jobico un patto lega l’uomo e l’Assoluto. È il patto sostanziato dalla giustizia di Dio, per cui Dio non lascerà mai morire il giusto. E Giobbe è angosciato perché tale giustizia, i cui princìpi comprende perché li riconosce inscritti nel suo cuore, tarda a rivelarsi, quasi Dio l’avesse smarrita. Se Socrate non comprende la sentenza dell’Oracolo, pur nella fiducia che non possa mentire, Giobbe non afferra i tempi e le forme di esecuzione della giustizia di Dio, pur non dubitando di essa. La zetesis socratica tesa all’elenchos è l’analogon del grido jobico: l’ineludibilità di quella ricerca e la pervicacia di quell’invocare nascono dalla stessa fiducia nella misura comune tra l’umano e il divino, e insieme sono modi per “mettere alla prova” il divino.
Al centro del Libro di Giobbe sta dunque la stessa questione agitata da Socrate: se la giustizia dell’uomo e quella di Dio siano legate da una misura comune o se un abisso le separi: se, diversamente detto, la condotta umana riceva valore in sé, dove sia retta, indipendentemente dal favore divino e dalle sue ricompense, benedizioni o maledizioni. Giobbe, nel difendere la propria giustizia, difende in realtà quella misura comune, l’eco di quella voce, il filo di quel religamen che si stende sopra l’abisso, e una sola cosa teme: il recidersi di quel filo, lo schiudersi del baratro dell’arbitrio divino. L’infinita distanza, il mistero delle vie con cui Dio attua la sua giustizia, lo stesso dolore, non fanno paura a condizione che quel filo, la misura comune, esista e tenga sul nulla.
La teodicea autentica di Giobbe, la sua difesa della iustitia Dei è, in realtà, la difesa di questa misura comune. Kant, nuovamente, meglio di ogni altro, ha visto nella moralità dell’Uomo di Us la base della sua religiosità, non bisognosa per giustificarsi, che di se stessa. Egli, infatti, ha dato prova «di fondare non la sua moralità sulla fede, bensì la sua fede sulla moralità» (Sul fallimento di tutti i tentativi filosofici in teodicea, in Id., Scritti sul criticismo, Roma-Bari 1991, p. 143). Su tale base etica si radica per Kant, dopo il fallimento di tutti i tentativi filosofici, l’unica possibile teodicea.
«Non si dà nessuna sospensione dell’etica, né dogmatica, né biblica, né liturgica» (p. 190).
conclude in questa direzione Mancuso. Dire che c’è una misura comune tra Dio e l’uomo, equivale a circoscrivere l’abisso del divino, a fissarne i bordi, a vincolarlo a una norma, a stringere un patto, ma anche ad aprire, nel divino, una ferita, un dramma: se, come nell’Eutifrone, una cosa non è santa perché amata dagli dèi, ma gli dèi l’amano perché santa, allora essi stessi dovranno essere santi. Dalla torsione socratica della logica religiosa sale un’istanza di emendatio che fonda la necessità di una teodicea: si Deus est, unde mala?
È, questo, un problema di cui l’autore de Il dolore innocente è ben esperto, in tutti i suoi abissi problematici. Tali sono alcune riflessioni che la lettura del libro di Mancuso mi ha suscitato, nella libertà del co-filosofare e nel solco di un comune itinerario di ricerca.
7. Una religio laici per il nostro tempo
Ha scritto Wilhelm Dilthey a proposito della corrente filosofico-teologica moderna da lui definita come «teologia trascendentale o speculativa», che la sciagura del protestantesimo (ma altrettanto ben vale per la Chiesa cattolica) è stata l’espulsione da sé di tale corrente. Ecco come il grande filosofo dello storicismo, di essa, fissa i tratti, definiti da un «cristianesimo dello spirito» toto coelo in linea col «cristianesimo dialogico» di Mancuso:
«La Chiesa protestante, per consolidarsi contro il cattolicismo, espulse da sé la prima di queste correnti, anzi la soffocò col sangue e con le rovine: e ciò fu la sciagura del protestantismo. Io ho chiamato trascendentale questa corrente: comunemente essa vien detta spiritualistica. Essa ammette una rivelazione universale, non limitata quindi esclusivamente alla Bibbia, bensì operante sempre e dappertutto. Da ciò nasce l’altra caratteristica di questa corrente, che sente e pensa Dio come esistente ed operante in tutto. E quindi essa inclina a interpretare quei dogmi, che presentano il peccato, la rivelazione e la salvazione sotto l’aspetto di fatti avvenuti una sola volta, come simboli di un processo interiore sempre in atto. E così al cristianesimo della lettera ne contrappone un altro dello spirito» (W. Dilthey, L'analisi dell'uomo e l'intuizione della natura. Dal Rinascimento al secolo XVIII, tr. it. Firenze 1974, p. 285).
Soffocati nel sangue, emarginati, perseguitati: tale è stato il destino dei pensatori che hanno cercato e incarnato una qualche figura di cristianesimo dialogico o, come dice Kant ne La fine di tutte le cose, da un «cristianesimo amabile e liberale». Ma, con la loro carne, con la loro parola, si è cancellata insieme una grammatica capace di pensare il religioso in una forma che non fosse quella confessionale, chiesastica, dottrinale, così alimentando l’idea di un aut-aut inesorabile, nella cui soffocante morsa tertium non datur: quello tra religione dogmatica, confessionale, cui si obbedisce in base al principio di autorità, e critica radicale della religione o ateismo. Di quella “terza via” secoli di persecuzione, come dicevo, hanno soppresso la Begrifflichkeit, la grammatica, il lessico, la logica. Per pensarla, direbbe Heidegger, manca il linguaggio.
Annullata quanto a possibilità di espressione, quella “terza via” finisce per essere ciò che Mancuso chiama «terra di nessuno», il ritrovarsi «nella scomoda posizione di essere “a Dio
spiacenti ed a’ nemici sui”» (p. 20): un metaxu abitato dai «perplessi», cui il teologo si rivolge con il suo libro, resi tali appunto da secoli di oblìo e cancellazione di un modo di essere religiosi diverso da quello confessionale e chiesastico.
Eppure, di quella grammatica, di quella concettualità, il pensiero europeo moderno e contemporaneo reca in sé la limpida traccia: si tratta della linea di pensiero, filosofica e teologica, che Mancuso pone sotto il segno del «cristianesimo dialogico», concetto non remoto da quanto Dilthey ha chiamato «teologia trascendentale» o da quanto personalmente definisco come «pensiero religioso liberale». Figure diverse per dire l’idea di una religio laici, di una teologia laica, di un pensiero religioso pensato a partire dal principio della libertà.
L’importanza cruciale del libro di Mancuso sta nel riordinare, ritessere – plectere da cui perplexus - i fili di quella grammatica, compitandola, quasi si direbbe, con esemplare limpidezza ed erudizione, rimettendo in circolo l’idea di un altro modo di essere homines religiosi. Io e Dio, liberta e Dio: proprio a simili diadi Jaspers si riferiva nella conferenza sull’umanesimo tenuta a Ginevra nel 1949. In essa, nel rispondere alla domanda «dove Dio ci parla?» («Wo spricht Gott zu uns?»), così rispondeva il filosofo:
«Dio parla solo mediante la nostra personale libertà […]. La Trascendenza parla alla libertà dell’essere se stesso (in der Freiheit des Selbstseins) in quanto organo in cui l’uomo, ogni uomo senza eccezione, direttamente di fronte a Dio, deve riceversi in dono per divenire autenticamente uomo» (K. Jaspers, Über Bedingungen und Möglichkeiten eines neuen Humanismus, in Id., Rechenschaft und Ausblick. Reden und Aufsätze, München 1958, pp. 317 e 340).
Roberto Celada Ballanti
