Breve itinerario di liberazione,
in libreria per Garzanti editore dal 14 novembre 2023
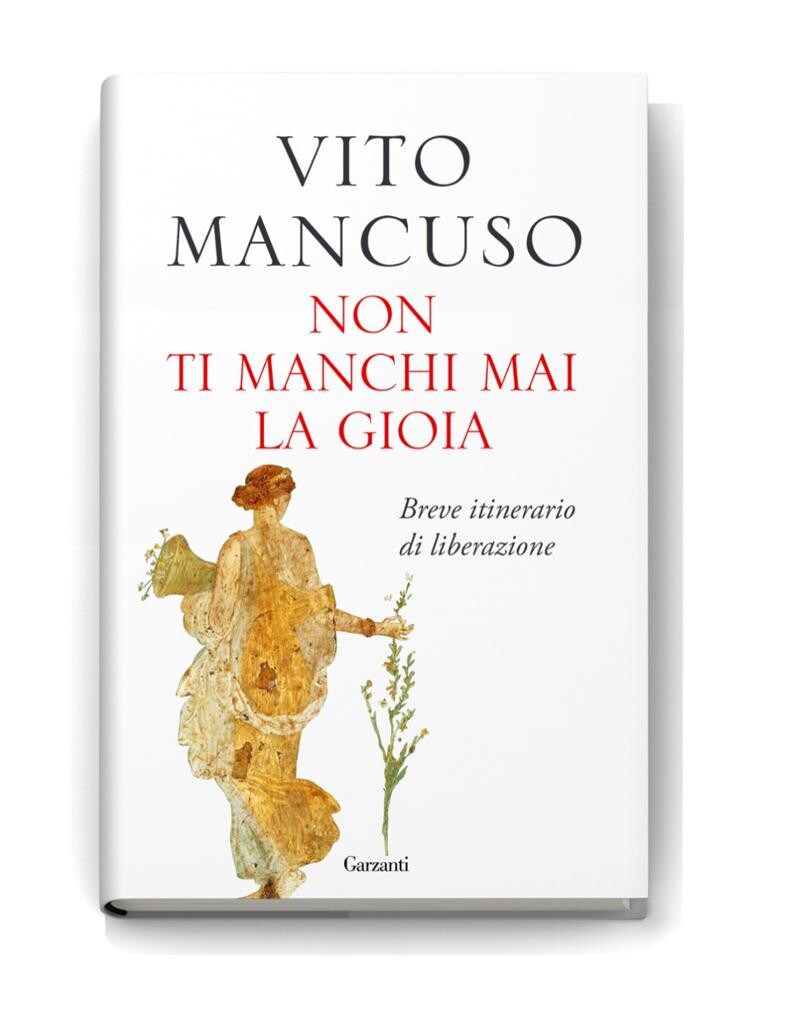
«A ognuno di noi capita di vivere momenti di stallo, quando non riusciamo a trovare la forza per andare avanti né sappiamo quale direzione prendere. La letteratura ci insegna che da sempre siamo in lotta con questa sensazione d’impotenza, ciò che è cambiato è solo il nostro modo di reagire. Se in passato cercavamo una via di fuga nella religione, oggi la troviamo in una nuova fede che celebra il culto dell’Io. L’inganno, però, è dietro l’angolo, perché nel credere soltanto in sé il narcisismo non fa altro che aggravare la propria prigionia.
Nel suo nuovo libro, Vito Mancuso propone una filosofia della liberazione per riconoscere e smantellare le trappole che attanagliano le nostre vite e aprirci a un’esistenza più autentica, fino a sperimentare la gioia profonda di vivere. Seguendo un cammino di piccoli ma costanti passi liberatori, scopriamo così che il destino di ciascuno si gioca nel mondo che portiamo dentro: perché se noi siamo la trappola, siamo anche il nostro liberatore. Approdando a questa consapevolezza saremo in grado di trovare equilibrio e generare limpida energia mentale, il più efficace strumento per la serenità e per la sorgente della gioia».
-
ISBN 9788811009764; pagine 144. È possibile ordinarlo negli store online. Per farlo segui i link indicati nel sito Garzanti.
Non ti manchi mai la gioia Garzanti [Link]
LIBERIAMOCI DAL DIO DELL’EGO
Da tempo ci siamo rifugiati nel culto di noi stessi e ci siamo trasformati nei nostri peggiori nemici. Ogni passione diventa una galera perché la cerchiamo al di fuori della spiritualità, ma lì sta la vera gioia. L’articolo di presentazione del nuovo saggio del prof. Vito Mancuso su la Stampa del 14 novembre 2023.
Non esiste epoca, stagione o anche solo momento dell’avventura umana che, risvegliandosi alla consapevolezza e all’onestà intellettuale (la forma più preziosa di onestà, da cui procedono tutte le altre), non abbia provato l’amara esperienza di essere in trappola. Le mitologie, le religioni, le filosofie ne danno ampia attestazione. Gli ambiti vitali, proprio perché danno vita e risultano indispensabili, legano a sé e quindi intrappolano. Nello stesso momento in cui ti danno vita, ti tolgono libertà. Tu non ne puoi fare a meno, e loro ti imprigionano dentro di sé.
Possiamo vivere senza l’amore? La risposta ovviamente è no, ma l’innamoramento e l’amore sono non di rado un assillo, un travaglio, un incubo da cui non si riesce a liberarsi. Lo mostrano Ovidio con Corinna, e tutta la letteratura universale che attesta l’assonanza, esistenziale oltre che linguistica, del binomio amore-dolore.
Shakespeare fa parlare così Romeo rivolto a se stesso mentre sente divampare l’amore per Giulietta: «Torna indietro, o inanimata argilla del mio corpo, e ritrova il tuo centro». La centratura più entusiasmante ma al contempo il decentramento più indebolente, la gioia più intima ma al contempo la sofferenza più penetrante, la generosità senza confini ma al contempo un astio altrettanto illimitato, provengono proprio da quel sentimento incontrastabile che chiamiamo amore.
Possiamo vivere senza la famiglia, o quella d’origine, o quella che ci siamo formata, o quella che vorremmo formarci, sia pure talora in forma diversa da quella tradizionale? No, c’è una tensione insopprimibile verso la vita insieme ad altri esseri umani.
Eppure, quanta prigionia proviene dalla convivenza degli esseri umani tra loro: per i figli, anzitutto, la cui crescita si compie come un progressivo cammino di autonomia denominabile guerra d’indipendenza; poi per i genitori, la cui prigionia è persino maggiore dato che si ritrovano da un lato inevitabilmente legati ai figli e dall’altro legati ancora agli anziani genitori sempre più bisognosi di aiuto, intrappolati in una manovra a tenaglia perfettamente riuscita. E quell’anello al dito? A chi non è capitato di percepirlo talora come una palla al piede, sentendosi proprio come quei galeotti di un tempo a cui veniva impedito il movimento con una sfera di piombo alla caviglia? Così ci si ritrova, volenti o nolenti (ma il più delle volte nolenti), a costituire una trappola gli uni per gli altri: a percepire il proprio marito, la propria moglie, i figli, la madre, il padre, gli altri eventuali parenti, persino gli amati animali domestici, come una trappola.
Senza calcolare che le trappole esteriori e più ancora interiori che ci provengono dalla famiglia sono così radicate in noi da passarci la vita dentro anche quando la famiglia non c’è più, o ce n’è un’altra. Non sappiamo dove si trovano, ma ne avvertiamo persistentemente il dolore che proviene dai meccanismi che le fanno regolarmente scattare.
E il sapere? Non ci sono dubbi che esso è lo strumento più efficace di liberazione, ma è altrettanto vero che può trasformarsi abbastanza facilmente in una catena tra le più pesanti. Che il sapere liberi è del tutto intuitivo, ognuno vede da sé come l’istruzione e la conoscenza dissipino la nebbia dell’ignoranza che impedisce di nominare la realtà per quello che è e che fa rimanere in balìa del pensiero altrui. Quando si sa, e si è in grado di esprimere quello che si sa, si è in possesso dell’arma principale per difendere la propria autonomia. Volendo il bene dei suoi ragazzi, e vedendo l’ignoranza a cui sarebbero stati destinati per il fatto di crescere senza istruzione nelle campagne del dopoguerra, don Milani, ben più che in chiesa, decise di condurli quotidianamente in classe e fondò la scuola di Barbiana.
Proprio per il suo potere cognitivo, però, il sapere può generare in chi lo possiede un atteggiamento di superbia e di chiusura che è una delle peggiori trappole della mente. Ci sono persone che ritenendo di sapere tutto non ascoltano autenticamente più niente e nessuno, se non quanto basta per criticare e confutare l’interlocutore e così esibire vittoriosamente il proprio potere intellettuale. Senza sapere si è preda dell’ignoranza, con il sapere si è a forte rischio di supponenza.
Il lavoro: anche solo per meri motivi economici non si può vivere senza, ma, quando si lavora, capita non di rado di sentirsi nel posto sbagliato, di provare la sgradevole sensazione di essere nulla più di uno strumento, un limone che altri stanno spremendo, in alcune circostanze addirittura uno schiavo alla catena.
Oggi il fenomeno della cosiddetta Great Resignation o Grandi dimissioni attesta esattamente questo malessere: si lavora perché non se ne può fare a meno, ma, non appena se ne può fare a meno, ci si dimette dal lavoro per ritornare padroni di sé. Per fare che cosa, però? In realtà, se non si ha un’occupazione tramite cui costruire qualcosa nella vita anche a prescindere dalla retribuzione (perché, potendoselo permettere, si può lavorare anche per puro spirito di volontariato), viene a mancare qualcosa di essenziale nella vita. Anzi, io penso che una delle più grandi fortune consista proprio nel trovare un lavoro che sia una grande passione che ci faccia lavorare intensamente. Se infatti lavorare stanca, è altresì vero che la stanchezza maturata facendo il lavoro che si ama è bellissima, appagante, di certo molto meglio della noia dell’assenza di attività.
È possibile continuare così per ogni altro ambito vitale: la passione politica, la passione sportiva, il gioco, il desiderio di viaggiare, gli amici, la religione… Tutto ciò che veramente riempie la nostra vita è al contempo causa di prigionia perché limita, e talora toglie, la libertà. Ne viene che di ogni persona o esperienza o ambito veramente importante siamo costretti a dichiarare sempre di nuovo: Nec sine te, nec tecum, vivere possum.
Per allentare i morsi della trappola e iniziare a intravedere l’itinerario di liberazione, e magari percorrerlo con qualche piccolo passo, ci aspetta oggi un compito diverso, per molti versi opposto rispetto a quello intrapreso dalla modernità: la modernità aveva dovuto superare Dio per affermare l’Io, oggi il nostro compito consiste nel superare l’Io per tornare ad affermare Dio. O, per meglio dire: il Divino, l’Indisponibile, l’Assoluto, il Gratuito, l’Inconoscibile, l’Apofatico, il Sacro, il Solenne, il Mistero, il Silenzio. È l’unico modo per uscire, almeno con la mente e con il cuore, dalla trappola.
Già nel 1966 Martin Heidegger, nella celebre intervista al settimanale tedesco «Der Spiegel» pubblicata come da accordi all’indomani della sua morte avvenuta dieci anni dopo, aveva dichiarato: «Ormai solo un Dio ci può salvare». Da che cosa il filosofo ricercava la salvezza? Dalla tecnica. Per lui infatti la tecnica nella sua essenza «è qualcosa che l’uomo di per sé non è in grado di dominare», ma da cui piuttosto è dominato: «La tecnica strappa e sradica l’uomo sempre più dalla Terra […] Tutto ciò che resta sono problemi di pura tecnica». Con questa conseguenza: «Non è più la Terra quella su cui oggi l’uomo vive». Parole che oggi, con le menti sempre più intrappolate nelle infinite connessioni della rete e sempre più distanti dal mondo reale, e con la Terra sempre più antropizzata e devastata, non si presentano più come un giudizio filosofico ma come la lampante constatazione di un dato di fatto.
I redattori del settimanale tedesco chiesero poi che cosa potessero fare il singolo individuo e la filosofia per contrastare questa situazione intrappolante, ricevendo la seguente risposta: «Se posso rispondere brevemente e forse un po’ grossolanamente, ma comunque in base a una lunga meditazione del problema: la filosofia non potrà produrre nessuna immediata modificazione dello stato attuale del mondo. E questo non vale soltanto per la filosofia, ma anche per tutto ciò che è mera intrapresa umana. Ormai solo un Dio ci può salvare». Cosa possiamo fare dunque? Ecco la risposta di Heidegger: «Ci resta, come unica possibilità, quella di preparare nel pensare e nel poetare una disponibilità all’apparizione del Dio o all’assenza del Dio nel tramonto».
L’unica possibilità di uscire dalla trappola, dice Heidegger, è renderci disponibili tramite il pensiero e la poesia all’apparizione nella nostra esistenza di ciò che poco più avanti egli denomina «l’altro pensiero», e a cui tradizionalmente ci si riferisce dicendo Dio, o anche divino. Tale apparizione può anche non avvenire, ma non è decisivo: se attesa, libera l’Io dal suo delirio di onnipotenza e ne dilata e ne ripulisce lo sguardo.
Vito Mancuso, La Stampa 14 novembre 2023
Recensione di Andrea Carandini sul Corriere della Sera, 4 dicembre 2023
Noi nella trappola dell'Ego [PDF]
Recensione di Arianna Tegani Commissione didattica Gariwo la foresta dei giusti 4 dicembre 2023
L’ultima opera del teologo e filosofo Vito Mancuso ha come sottotitolo “Breve itinerario di liberazione”: da cosa? Dalle trappole del nostro tempo che, attenti bene, non sono le difficoltà o le situazioni problematiche che ogni giorno affrontiamo. Trappola è piuttosto tutto ciò che ci lega in modo insostenibile ma senza il quale non possiamo vivere. Detto con la formula di Ovidio (nel descrivere il suo rapporto con Corinna): “Né senza di te né con te sono capace di vivere”.
Mancuso è convinto che l’essere intrappolati sia la condizione strutturale dell’essere umano autenticamente pensante, un essere che non pensa a sé stesso ma pensa sé stesso, “nella propria radicale solitaria singolarità” (p. 14). Solo nella solitudine “sale dal profondo una voce che ti dice: sei in trappola” perché, con l’onestà intellettuale del pensiero, sperimentiamo che tutti gli ambiti vitali che ci danno vita e di cui non possiamo fare a meno, ci tolgono anche la libertà. Possiamo vivere senza l’amore? No certamente! Ma quanti assilli e travagli genera! Così è per la famiglia, il sapere e la conoscenza, il lavoro, la politica, la religione, le passioni sportive e artistiche… e l’elenco potrebbe essere lungo.
Ma cosa significa pensare? Non significa avere informazioni, conoscenze, contenuti, opinioni. “Pensare è dirigere. Il pensiero è la struttura in base a cui un essere umano si muove nel mondo e compie o non compie delle azioni: sceglie chi incontrare… di cosa nutrire la sua psiche… il suo spirito… come parlare” (p. 25). Capovolgendo l’affermazione di Feuerbach (“L’uomo è ciò che mangia”) Mancuso sostiene che “l’uomo è ciò che pensa” perché da questo nostro personale centro interiore dipende ciò che per noi ha valore nella vita, come diceva Hannah Arendt: “Ciò che si fa dipende da ciò che si è” (p. 26). Da ciò che si vuole essere, dal nostro principio-direttivo, la guida del nostro vivere, dipende la nostra esistenza.
Questo principio è stato chiamato da tutte le culture Dio, inteso non solo come principio metafisico e trascendente, il Dio di una qualche religione ma come la “condizione necessaria dell’esistenza a livello psichico… un ideale… uno scopo… un valore in base a cui vivere, lavorare, progettare, sognare e anche morire”. Ciò che chiamiamo Dio ha subito profonde metamorfosi nella nostra cultura Occidentale: si è passati dal divino della Natura e della Cultura in Grecia, al Dio cristiano del medioevo, sostituito poi dalla divinizzazione dello Stato in epoca moderna. E oggi? Dopo la “morte di Dio” prefigurata da Nietzsche “oggi è subentrato nella psiche degli umani postmoderni il Dio immanente e privatissimo dell’Io. La sua dogmatica si chiama finanza, la sua liturgia shopping… Il Dio dei nostri giorni si chiama Io. Noi viviamo nel tempo del Dio Io” (p. 29).
Sull’altare dell’Io immoliamo e nullifichiamo il rispetto per gli altri, la natura, i diritti di uguaglianza e giustizia. Piuttosto inneggiamo al nostro interesse privato, alla nostra volontà di potenza-prepotenza, alla violenza e alla guerra di tutti contro tutti.
Mancuso tratteggia le cinque trappole sociali del nostro tempo: la democrazia formale contro la democrazia sostanziale che porta al disprezzo per il bene comune e per la cura dei valori civili; l’economia contro l’ecologia, dimenticando il rispetto per l’ambiente; l’identità contro l’accoglienza che si esprime nel sovranismo; la tecnologia contro la coscienza che guarda agli esseri umani solo come operativi, efficienti, performativi e la sicurezza contro la pace perché il possesso e l’uso delle armi non fanno che esprimere la guerra di tutti contro tutti. Stiamo perdendo il fondamento della societas e della convivenza umana su questo pianeta.
“Coloro che credono solo in sé stessi in realtà non credono, sono atei nel senso esistenziale di ateismo: sono cioè nichilisti per i quali nulla ha valore in sé, perché tutto è funzionale a sé stessi” (p. 31).
La trappola strutturale è quindi dentro di noi: l’essenza umana è caratterizzata non solo dalle nostre peculiarità fisiche, psichiche e intellettuali ma da uno “spazio vuoto”, al fondo di noi stessi, che ci rende non-finiti, in-definiti, “forse persino in-finiti” (p. 55). Questo vuoto produce una tensione che Spinoza chiamava “cupiditas”, una sorta di risucchio che ci rende inquieti, sempre in tensione. Come affermava Pascal: “Ho scoperto che tutta l’infelicità degli uomini deriva da una sola causa: dal non saper restarsene tranquilli, in una camera”. “Ecco perché agli uomini piace tanto il chiasso e il trambusto” (p. 57). Noi oggi siamo voraci di informazioni, di contatti, di cibo, di fumo, di alcol e droghe, di visibilità, del continuo viaggiare e spostarsi; ci sentiamo vivi solo se desideriamo. Se la cupiditas non si trasforma in amore, secondo Spinoza, il nostro Dio-Io si costruisce una dolorosa prigione. In quel laboratorio che è la nostra vita, in cui stiamo conducendo l’unico esperimento che deciderà di noi stessi, dobbiamo essere consapevoli che il pensare rettamente è l’unica via d’uscita.
“Il fondamento del retto pensiero è la scelta per il bene e la giustizia” (p. 74): il fondamento etico costruisce il nostro sguardo, la conoscenza di noi stessi, degli altri, del mondo. Il pensiero imprigiona ma anche libera, libera dalle malattie mentali che oggi più che mai assediano giovani e vecchi: ansia, depressione, psicosi, disturbi alimentari… non sono che la concretizzazione di “false opinioni sul senso e il valore della vita” (p. 77) che assolutizzano il denaro, la furbizia, la simulazione, un certo tipo di bellezza, la sessualità senza rispetto. Mancuso tratteggia un possibile percorso di liberazione: tre sono le tappe importanti, i pensieri giusti che aprono possibilità di liberazione e soprattutto di gioia.
Il primo: “consiste nel concepire tutto a partire e in funzione di qualcosa di più importante di sé” (p. 81). Possiamo chiamarlo natura, giustizia, bellezza, ideale, arte, scienza: lo spazio vuoto dentro di noi, che cerchiamo di non ascoltare o di riempire con inutile caos, a volte con “spazzatura”, può cambiare direzione se si trasforma in accoglienza di “qualcosa o qualcuno più importante di sé” (p. 84) per cui vivere, a volte anche morire, passando dalla nostra volontà di potenza/prepotenza alla volontà di relazione. “La cosa più importante di me che merita la mia dedizione …si può chiamare bene. Anzi il Bene” (p. 86) che tanta tradizione filosofica e spirituale ha fatto coincidere con una presenza divina nella profondità umana. Etty Hillesum diceva: “Chiamo Dio la parte più profonda e migliore di me”. Hannah Arendt parla di “radici dell’io”: per chi, come essere pensante, “sa di dover vivere con sé stesso, ci saranno limiti a ciò che si permetterà di fare, e tali limiti non gli verranno imposti dall’esterno, ma dal suo stesso io… il male estremo e senza limiti è possibile solo quando queste radici dell’io, che crescono da sé e arginano automaticamente le possibilità dell’io, sono del tutto assenti. Quando sono del tutto assenti? Quando gli uomini pattinano sulla superficie degli eventi, quando si fanno sballottare a destra e a manca senza dar prova di quella profondità di cui pur sarebbero capaci”.
Il secondo pensiero giusto, secondo Mancuso, è liberarsi dalla ricerca dell’acclamazione sociale e del successo che crea dipendenza: il baricentro esistenziale è in me, la posta in gioco è ciò che comunemente si chiama “anima” o coscienza. Scriveva Bonhoeffer nel maggio 1944 dal carcere di Tegel: “Compito della nostra generazione non sarà «cercare grandi cose» ma salvare e preservare la nostra anima dal caos” (p. 96). Come non pensare alla situazione “fluida” di tanti giovani (ma anche adulti!) che non riescono a mettere radici in sé stessi, perdono fiducia e speranza inghiottiti da un marasma di eventi, notizie, sguardi apocalittici che tolgono il respiro. L’anima, il nostro spazio-vuoto interiore, non è il nulla ma, come il vuoto quantistico “è cosa viva, sostanza dinamica e incessantemente mutevole, gonfia di potenzialità, gravida di opposti” come afferma il fisico Tonelli (p. 96). Questa scintilla interiore fa dell’anima non una sostanza, perché non è una realtà permanente (a volte si defila, come con grande ironia, racconta la poetessa Wislawa Szymborska in “Qualche parola sull’anima”) ma sempre ci identifica.
Il terzo pensiero giusto è quindi custodire, predisporre il nostro spazio del cuore: si può pulire la nostra interiorità lavorando su stessi e scegliendo le poche cose, persone, esperienze davvero importanti della vita. Come diceva Montaigne: “Bisogna riservarsi un retrobottega tutto nostro, del tutto indipendente, nel quale stabilire la nostra vera libertà, il nostro principale ritiro e la nostra solitudine” (p. 105). La nostra anima o coscienza nasce nel silenzioso dialogo con sé stessi: perdere la solitudine significa perdere l’io che costituisce la persona, significa perdere l’io come canone ultimo della condotta morale.
E la gioia? Mancuso immagina di parlare a studenti delle superiori il primo giorno di scuola, sintetizzando il percorso di liberazione che ha tratteggiato. Centro del suo discorso sono le parole di Seneca a Lucilio (discepolo che rappresenta ognuno di noi):
“Prima di tutto fa’ così, Lucilio mio: impara a gioire… voglio che non ti manchi mai la gioia. Voglio però che ti nasca in casa: e ti nascerà se sorge dentro di te… La gioia di cui ti parlo, e alla quale cerco di condurti, è invece fondata e si genera intensamente nell’interiorità… aspira al vero bene e godi del tuo. Ma cos’è questo tuo? Sei tu stesso, è la parte migliore di te” (p. 121).
Questo itinerario di liberazione proposto da Mancuso sostiene anche l’attività dei Giardini: perché onoriamo i Giusti? Perché ci affascinano? Perché ci danno speranza? Perché desideriamo soprattutto farli conoscere ai giovani?
Il metodo di Gariwo promuove e costruisce l’incontro con donne e uomini esemplari in questo modo: con l’educazione alla gratitudine dal basso per “valorizzare le persone migliori che in ogni tempo e luogo si sono prese cura dell’umanità… per prevenire il Male”. Questo permette di guardare agli esempi concreti delle persone meritevoli che possono diventare un punto di riferimento morale. “Si educa l’opinione pubblica a sviluppare un gusto estetico, riconoscendo la bellezza della persona buona”, contrastando l’indifferenza e promuovendo esempi di eccellenza morale. Inoltre, cerca di trasmettere una conoscenza dei fatti per sentirci tutti cittadini del mondo: se non si conosce non si può agire. Ciò che accade in Afghanistan, Iran, Cina, Russia… è anche affar mio, affar nostro: a partire da una situazione locale, si può costruire uno sguardo empatico sul mondo per sentirsi appartenenti ad un comune destino di cui siamo responsabili.
Infine, si rivolge ai ragazzi e alla società attraverso un meccanismo di comunicazione indiretta: come afferma Pierre Hadot, l’educazione deve essere persuasiva perché non si impone a nessuno un comportamento: "al richiamo del Bene non si ubbidisce come a un ordine militare ma si arriva attraverso un percorso solitario di purificazione morale", fatto di attrazione e di libertà. Le riflessioni di Mancuso ci dicono che siamo sulla strada giusta ogni volta che la gioia fa capolino nelle nostre attività. Quando come ospite inatteso arriva, non abbiamo dubbi: fioriscono le persone, fiorisce la vita. A partire dalla scuola!
